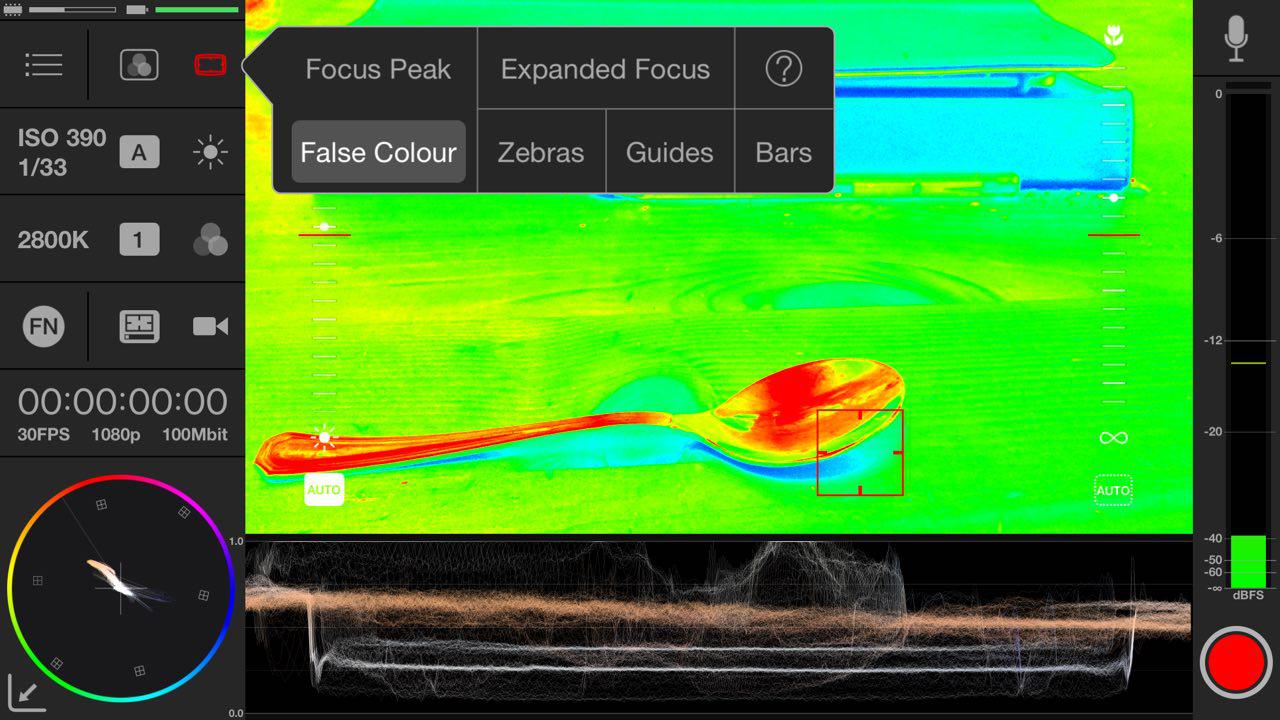Oggi pomeriggio la notizia e i commenti si susseguono ancora.
Allora, ho alcune notizie fondamentali sulla community internazionale dei mobile journalist che in queste ore sta fibrillando e non poco. Quali sono? Vado con ordine: il grande capo di Mojocon, la Mobile Journalism World Conference, sto parlando di Glen Mulcahy, ha lasciato la tv di stato irlandese RTE. Il tutto dopo aver fatto nascere e crescere la community internazionale della mobile content creation nell’arco di tre edizioni di una manifestazione nella quale ha riunito il meglio al mondo di questa cultura. Nella community si sapeva, ma non c’era alcun accenno di futuro per la manifestazione. Si sapeva dell’addio di Glen a RTE, ma non del destino di Mojocon. Fino a oggi pomeriggio.
Con un “Important Announcement” proprio Glen Mulcahy ha comunicato di aver ricevuto dall’azienda dalla quale è dimissionario, l’invito formale a chiudere la fanpage di Facebook di Mojocon e l’account Twitter di Mojocon. La notizia ha scatenato un putiferio di commenti che si stanno susseguendo anche in questi minuti, dato che la community dei mojo abbraccia fusi orari da Brisbane a New Dehli.
Il futuro è adesso.
Alcune indiscrezioni erano filtrate nei giorni scorsi e facevano pensare a una continuità del binomio RTE e Mojocon, magari nelle mani del geniale Philipp Bromwell. La mannaia sugli account, però, ha fatto comprendere che il broadcaster di Dublino ha considerato, di fatto, l’attività di Mojocon una fringe activity, decidendone la chiusura ufficiale. Il tutto considerando anche il piano di crisi da 250 licenziamenti che deve fronteggiare. La notizia è, tuttavia, anche simbolica rispetto al momento della community del mobile journalism. Il mojo non è ancora considerato centrale per il futuro delle tv e dei broadcaster che continuano (sbagliando) a considerare i modelli produttivi classici come gli unici possibili per la tv di oggi. Presto si accorgeranno dell’errore.
Un account twitter conta
Questa richiesta di RTE a Mulcahy, di zittire le tracce ufficiali di Mojocom, ha accellerato, tuttavia, i propositi dello stesso Mulcahy che, per storia personale e per l’impresa di aver realizzato Mojocon, è considerato il capo della community mondiale. Il giornalista di Waterford, stante il veloce avanzare degli eventi, ha rivelato a tutti alcune delle caratteristiche di un nuovo progetto di evento per la comunità Mojo. Innanzitutto ha aperto questo account Twitter che, già dalla bio, sembra dire molto: “More than just a conference, Mojofest is the next evolution in Mojo, a celebration of the creative community that harness smartphones for digital storytelling.”.
Si parlerà anche di Cinema…
L’idea è chiara ed è quella di creare un evento nel quale l’idea di Festival e l’idea di Creatività siano centrali rispetto al solo mondo del giornalismo. Il tutto per aprire, appunto, a un pubblico molto più vasto rispetto a quello dei media, le vie di una cultura professionale che può cambiare molte vite e molte differenti carriere. Molto indicativo, in questo senso, un commento fatto da Glen Mulcahy a Michael Koerbel che è uno dei primi film maker con smartphone al mondo. Era incentrato sul fatto di inserire anche il mondo della creatività cinematografica nel percorso di realizzazione di questo nuovo soggetto che unirà la community mojo. La notizia della morte di Mojocon, quindi, ha avuto l’effetto di una bomba, ma ha anche liberato l’energia di una community che ha compreso che RTE non farà ombra a una nuova creatura “targata” Glen Mulcahy. Un bene, non ci sarà, quindi, l’imbarazzo di scegliere fra una Mojocon targata RTE, ma senza Mulcahy e un nuovo soggetto di Glen.
La squadra? A naso centra la Thomson, ma non solo…
Credo anche che Glen Mulcahy stia già riunendo attorno a se la squadra che sarà il motore di MojoFest, questo il nome del nuovo soggetto. Mi avventuro anche in qualche nome della community come Mark Egan, Nick Garnett, Wytse Wellinga, Yusuf Omar e la sua signora Sumaiya, Douglas Show, Chris Birkett. Perché lo dico? Perché questi sono anche buona parte dei nomi del progetto di e-learning di Thomson di cui ho parlato nell’ultimo pezzetto pubblicato.
Alla fine un documento importante.
Prima di lasciarti andare a dormire ti giro un documento importante che la collega Corinne Podger aveva realizzato dopo Mojocon 2017. E’ un documento online con gli attacchi a tutti i panel si Mojocon 2017, il cui canale Youtube resterà attivo. Vale la pena tenerlo, perché è stato un momento storico per la mobile content creation. La community, quindi, è in fibrillazione ma è più viva che mai. Il tutto anche se le pressioni del mondo della produzione broadcast sono comunque molto forti e impediscono la crescita di un movimento che, prima o poi, sfonderà. In quel momento sarai lì, con me, a goderti lo spettacolo.